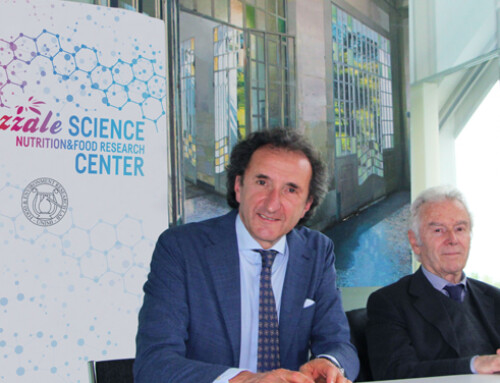L’etichetta, e più in generale la veste grafica di un prodotto alimentare, ha una funzione, tra le altre, che non viene sempre considerata come merita: quella di creare un contesto emotivo che condizioni positivamente l’esperienza del consumo. L’etichetta non solo può darci informazioni sull’alimento: cos’è, di cosa è fatto, chi lo ha fatto, dove e quando, ma può anche associargli qualità espressive che esso non possiede di per sé, e costruire un discorso complesso sia sull’alimento sia sulle persone che potrebbero desiderarlo.
A questo proposito, qualche anno fa a Londra, ho avuto un’esperienza rivelatrice, che racconto spesso come esempio. Mangiavo pere disidratate nell’underground, da una busta da 100 grammi che avevo appena acquistato in un supermercato Waitrose. Era di un marchio allora relativamente nuovo, Urban Fruit, che proponeva ai consumatori londinesi i benefici della frutta in questo formato pratico e tascabile. Sulla confezione c’era una grafica fresca, semplice e spigliata che metteva di buon umore. “Frutta urbana” era un nome decisamente centrato e con quel sacchetto colorato in mano, seduto al mio posto, mi sentivo in armonia coi tempi e con il luogo, e avevo la sensazione di avere fatto una scelta moderna, divertente e sana, in linea con la nozione più aggiornata di buona alimentazione.
Si trattava di frutta disidratata, niente di più. Dello stesso tipo che si trova da sempre, sfuso e venduto a peso, nei mercatini rionali. Quella che abbiamo acquistato tante volte come un dolciume, soprattutto sotto le feste, e che il venditore raccoglie con la paletta per metterla nei sacchetti di carta. Il prodotto, o meglio, la cosa che si mangia, è la stessa eppure l’esperienza è diversa. Se a Londra avessi avuto in mano, anziché Urban Fruit, un sacchetto di carta kraft con dentro mezzo chilo di pere disidratate, queste forse mi sarebbero piaciute lo stesso, ma non mi sarei sentito altrettanto cool e la mia scelta non mi sarebbe sembrata poi così sana e moderna.
Mi fu chiaro allora che il packaging e la sua grafica avevano influito sugli aspetti emotivi dell’esperienza rendendola più gratificante. Avevano creato valore.
I formaggi al supermercato
La funzione patemica del packaging, come la definirebbero i semiologi, quella per cui il packaging riesce a generare specifiche emozioni in chi lo osserva e lo maneggia, è molto importante nella grande distribuzione. Al supermercato, il prodotto si deve raccontare da sé. Non c’è nessuno lì vicino che sia in grado di ispirare fiducia e di elaborare un racconto convincente e seduttivo del prodotto. Può farlo solo il packaging, con l’obiettivo di creare nel consumatore un pregiudizio positivo e uno stato d’animo euforico e ricettivo che lo predisponga al gradimento.
Per i grandi marchi come Galbani o Parmareggio, la presenza del logo sul packaging è sufficiente perché nelle menti di un’enorme quantità di persone si attivi una catena di associazioni che la inducono ad acquistare il prodotto e poi a trovarlo buono o comunque corrispondente ai loro bisogni. Questo accade perché le aziende hanno investito molti soldi nel costruirsi una solida reputazione a livello nazionale.
Nei formaggi preincartati, invece, il nome del produttore conta poco e viene a malapena citato nell’etichetta. D’altronde, a parte rare eccezioni come Lattebusche e Occelli, che sono aziende abbastanza grandi da sostenere investimenti nella comunicazione, il nome del produttore non direbbe niente al consumatore medio. Nell’orientare le scelte conta molto di più la denominazione, meglio se protetta: IGP, DOP ecc. Del taleggio DOP mi interessa prima di tutto la certificazione; che sia prodotto da uno o da un altro nel contesto di un supermercato non fa grande differenza. Anche l’esposizione è importante: se i preincartati sono esposti in un’isola progettata per esaltare il loro valore gastronomico, ad esempio collocata vicino al banco taglio e realizzata con un look & feel di pregio, la loro qualità percepita aumenta. Analogamente, se sono commercializzati con il marchio di alta gamma del distributore, come Fior Fiore Coop o Sapori & Dintorni Conad, saranno considerati come i campioni di una selezione rigorosa di eccellenze gastronomiche. In tutti i casi la funzione patemica è delegata al distributore e il nome del produttore resta sullo sfondo, per lo più ignorato.
Il carrello dei formaggi
Veniamo al tema di questa iniziativa. In che modo un’etichetta ben fatta potrebbe creare valore al ristorante? Che senso avrebbe un investimento sulla propria immagine da parte del produttore?
Nel ristorante in effetti c’è già un contesto emotivo favorevole: ci sono il carrello e la carta dei formaggi, e un cameriere esperto che ne racconta le origini e le qualità organolettiche e che esalta le virtù dei casari e degli affinatori. Se mi sono trovato bene, e sono contento dell’atmosfera e delle altre cose che ho mangiato, il mio palato è già predisposto ad accogliere la promessa di un nuovo piacere. Nessuna etichetta potrà mai fare niente di meglio. L’unica funzione che potrebbe avere un’etichetta qui è quella di promemoria. Similmente a quanto avviene con i vini, potrei aver voglia di fotografarla col cellulare o prendere nota del nome del casaro per poi cercarlo su internet e capire come acquistare quel formaggio che mi è piaciuto così tanto. Tutto questo ammettendo che il gestore non sia geloso dei suoi fornitori e sia disposto a condividerne i contatti con i clienti, così che possano ripetere l’esperienza anche senza venire al ristorante.
Un’etichetta studiata per la funzione di promemoria potrebbe avere un aspetto molto diverso dai classici incarti in papier pelure. Dovrebbe essere una presenza discreta sul carrello o sulla tavola, qualcosa che non interferisca con la qualità dell’esperienza. Un tema stimolante e delicato per un designer. L’etichetta in questo contesto rischia di avere addirittura un effetto negativo, definendo il formaggio a cui è associata come un prodotto commerciale, anziché come una gemma scovata per noi dallo chef in una fossa remota. Le etichette alludono alla produzione in serie e non sono benvenute sulla tavola di un ristorante. Le uniche ammesse, e anzi richieste, sono quelle del vino, perché per una bottiglia di vino l’etichetta è la sua identità. Da una bottiglia senza etichetta ci si aspetta un vino generico, sfuso, della casa. Gradevole magari, ma senza carattere e senza storia. Col formaggio accade il contrario. A differenza del vino ogni pezza di formaggio ha una forma propria e tratti distintivi riconoscibili, che lo rendono unico: la crosta, le muffe, la grana, l’occhiatura, l’unghiatura, le crepe… L’essere privo di etichetta, anziché diminuirlo a formaggio generico, ne rafforza il carattere di prodotto genuino e autentico.
Quindi?
Ammesso che si trovi un modo appropriato, cioè elegante e discreto, per valorizzare all’interno del ristorante i produttori e gli affinatori dei formaggi selezionati dallo chef, in modo che gli avventori abbiano l’opportunità di stabilire un qualche rapporto con loro anche fuori dal ristorante, emerge il tema della qualità di questo rapporto. Dopo un’esperienza gastronomica sublime, mi potrebbe accadere di imbattermi in un sito spoglio e poco curato che restituisce un’immagine dell’azienda non all’altezza del formaggio che ho assaggiato: un logo a forma di festone con i colori della bandiera italiana, un paio di caprette sorridenti illustrate con tratto infantile, forme di caprino anodine scontornate alla buona e messe su uno sfondo bianco latte, testi in caratteri handwriting di varie dimensioni, album fotografici amatoriali che mostrano le varie fasi della lavorazione nella luce asettica del laboratorio… Niente di più lontano dalla magia che si era creata al ristorante. Il ricordo di quanto era buono il formaggio probabilmente avrebbe la meglio e mi indurrebbe comunque a fare il possibile per averne ancora un pezzo, ma la dissonanza cognitiva avrebbe inevitabilmente un impatto negativo. L’immagine dell’azienda non riuscirebbe a creare un contesto emotivo nemmeno lontanamente paragonabile a quello del ristorante e il secondo assaggio, a casa mia, potrebbe non convincermi come il primo al ristorante.
Ecco, io sposterei l’attenzione da quello che accade al ristorante a quello che accade dopo il ristorante. È lì che avrebbe molto senso investire energie e denaro perché è lì che il marchio deve parlare nel modo giusto, per non sprecare il capitale di reputazione accumulato grazie alle parole di un cameriere esperto, a un ambiente valorizzante e a una memoria di piacere.
Un lavoro di branding ben fatto, cioè la costruzione di un’immagine efficace e convincente per il proprio marchio, ha un costo. Un costo accessibile, in realtà, ma che molte piccole imprese non sono disposte a sostenere, perché considerano il branding un esercizio superfluo: un rivestimento elegante, ma tutto esteriore, di un valore reale che esisterebbe comunque. Pensano che la qualità intrinseca dei loro prodotti basti a soddisfare i clienti e a fidelizzarli e che il problema stia tutto nel farsi conoscere. Se riuscissero a cambiare la prospettiva sul branding a vederlo per quello che è davvero, cioè una parte integrante e costitutiva del valore dei loro prodotti, come mostra l’aneddoto delle pere secche, non parlerebbero più di rivestimento, ma di investimento.